Programma speciale a cura di Francesco Vitucci
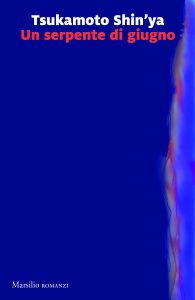 Tradotto per la prima volta in italiano dalla casa editrice Marsilio (traduzione di Francesco Vitucci) con una copertina disegnata dallo stesso autore, Un serpente di giugno è la novelization dell’omonimo film scritta dal suo stesso regista.
Tradotto per la prima volta in italiano dalla casa editrice Marsilio (traduzione di Francesco Vitucci) con una copertina disegnata dallo stesso autore, Un serpente di giugno è la novelization dell’omonimo film scritta dal suo stesso regista.
Un serpente di giugno di Tsukamoto Shin’ya è un romanzo di violenza e compassione, un thriller di pulsioni contrastanti che riscrivono il concetto di morale attraverso tre voci, ognuna portatrice di una verità inquietante.
In una metropoli giapponese investita dai monsoni, Rinko, una timida consulente di una hotline dedicata ai disturbi della psiche, conduce un’esistenza insoddisfatta, inchiodata a una vita senza sesso col marito Shigehiko. Sarà una busta con alcune foto sconvenienti a innescare la vicenda: un suo paziente intende ricattarla per indurla a dare sfogo a fantasie sessuali che lei stessa scoprirà di avere. Persa ogni inibizione, Rinko capisce che il suo aguzzino, un fotografo di mezza età su cui incombe l’ombra della malattia, sta cercando di salvarla da un pericolo mortale. Quando Shigehiko scoprirà le foto, il fotografo lo punirà per la sua mancanza di attenzione nei confronti della moglie.
Se l’omonima trasposizione filmica girata dallo stesso Tsukamoto è un’implacabile sequenza d’immagini compresse, disturbanti, il romanzo ne amplifica il respiro mantenendo intatta la ferocia originale. Il risultato è un cinema verbale a tinte fosche, madido di pioggia, sudore e umori femminili, dove il dramma psicologico brilla in azioni fulminanti, oscene, come un paesaggio desolato sotto scoppi di fulmini improvvisi.
Parlando del suo lungometraggio, girato in bianco e nero per essere ricolorato in blu in postproduzione, Tsukamoto ha affermato che Il serpente di giugno gli è stato suggerito “da un unico disegno che ho fatto da bambino, una lumaca su un’ortensia. […] Quando ripenso a quell’immagine, mi torna in mente l’aria azzurra e trasparente intorno al fiore. Realizzando questo film ambientato nella stagione delle piogge, ho avuto l’impressione che quello stesso azzurro mi abbia indicato la direzione da seguire. Nell’estrema volgarità della vicenda, volevo vedere qualcosa di puro, nobile, un tratto che mi fosse caro. Ai tempi di Tetsuo e Gemini stavo già inseguendo l’idea di realizzare Il serpente di giugno, [un’opera che è un] canto di erotismo nonostante i personaggi non abbiano alcuno scambio fisico fra loro”.
C’è però un contatto acustico che ha qualcosa di carnale, soprattutto nel romanzo, dove il fuoco narrativo interno a Rinko ci costringe a percepire col suo udito la voce del fotografo impartirle ordini al telefono. La donna è posseduta da una voce che la penetra a distanza, mentre l’obiettivo della fotocamera è anche l’occhio del lettore, testimone muto di un piacere ritrovato. In questo vortice di erotismo inconfessato c’è una dimensione terapeutica. Come ne La chiave di Tanizaki Jun’ichirō il professor Kimura spera che la moglie scopra il suo diario intimo, anche Rinko, nel profondo, nutre la speranza che il marito trovi gli scatti incriminati. Quello che può sembrare un desiderio di espiazione, in realtà, è l’epilogo di una terapia emotiva, e il bacio fra Rinko e suo marito, primo e ultimo contatto fisico in questa storia dove l’eros è un attributo della mente, appare come l’estrema trasgressione di due corpi che tornano a sfiorarsi.

Shinya Tsukamoto arrives as Paramount Pictures present the Los Angeles premiere of “Silence” at the Directors Guild of America in Los Angeles, CA on Thursday, January 5, 2017
(Photo: Alex J. Berliner / ABImages)
BIOGRAFIA
A soli quattordici anni, Tsukamoto ha tentato di sperimentare con una 8 mm una personale idea di cinema visionario, alla quale ha poi dato graduale compiutezza nel corso della sua lunga carriera. Lo hanno aiutato anche i suoi primi studi di pittura a olio, una certa esperienza nell’ambito pubblicitario e la libertà creativa di cui dispone nel piccolo gruppo teatrale Kaiju Gekijo (Teatro dei mostri marini) che ha fondato nel 1985 ispirandosi a vari movimenti underground come quello di Shuji Terayama.
Dopo alcuni interessanti cortometraggi, tra cui Mostri di grandezza naturale (Futsu saizu no kaijin, 1986) e Le avventure di Denchu Kozo (Denchu Kozo no boken, 1987, Gran Premio al Pia Film Festival di Tokyo), nel 1989 ha girato il suo primo film in 16mm, Tetsuo (id.), grazie al quale ha ottenuto nello stesso anno il Gran Premio al Fantafestival di Roma e l’improvvisa popolarità nei circuiti di cultori del genere. Giunge quindi la chance di realizzare un film in 35 mm per la major Shochiku, con un discreto budget e interpreti importanti, progetto da cui è nata la favola-horror Hiruko – Il cacciatore di fantasmi (Hiruko – Yokai hantå, 1991), ma il regista è presto tornato alla sua produzione indipendente con Tetsuo II – Body Hammer (id., 1992), Tokyo Fist (id., 1995), Bullet Ballet (id., 1998, film con cui ha ampliato la formula di lotta tra uomo e habitat a quella di differenti generazioni di “mutanti”). Raccolto ormai un pubblico di cultori di tutto rispetto a livello internazionale, la seconda opera importante in termini di budget è realizzata per la major Toho Sedic, Gemini (Soseiji, 1999, dall’omonimo racconto di Edogawa Ranpo), primo film in costume per quest’autore.
Seppure manifestata con minore evidenza nel film Hiruko, tutto il cinema del primo periodo di Tsukamoto parte da e si sviluppa intorno all’idea che l’essere umano viva in un contesto urbano composto di cemento e metallo che si estende a dismisura fagocitando spazio e carne umana, fino a ridurre l’uomo al solo cervello. Sta a noi, dunque, riappropriarci della nostra materia lottando con la sostanza inorganica che ci soffoca, sferrando pugni (il tema di Tokyo Fist) per infrangere gli eccessi di habitat e svelando il sangue di cui siamo composti per ridefinire la fisicità dei nostri corpi. Il suo cinema è quindi visualmente molto forte e ricorre spesso alla potenza immaginifica dei manga di cui Tsukamoto riconosce una certa influenza (soprattutto dagli anime Gamera e Ultra Q): con agilissimi movimenti di macchina, rappresenta la carne mentre si fonde con il metallo (Tetsuo e Tetsuo II), mette in scena apocalittiche e cyberpunk devastazioni e abnormi fiotti di sangue, piercing, violenze sul corpo al fine di definirlo, geometriche e metalliche rappresentazioni urbane (visualizzate al meglio dai bianchi, neri e grigi toni di Tetsuo e Bullet Ballet), richiama instancabilmente l’idea che esista la possibilità di perdere la vita anche in una società che — sostiene l’autore — si ritiene invulnerabile come quella giapponese. Si succedono nei film scene veloci e violente riprese con l’estrema libertà dei movimenti di macchina con cui Tsukamoto sapientemente calibra il mutare dei corpi.
La ricerca quasi “fisiologica” dell’essere umano continua con il film Un serpente di giugno (Rokugatsu no hebi, 2002), vincitore del Premio Speciale della Giuria nella sezione Controcorrente della Mostra del Cinema di Venezia. La distribuzione del film, inoltre, è accompagnata in patria anche dalla pubblicazione dell’omonimo romanzo scritto dal regista, ora edito in Italia da Marsilio Editore.
La carne e la mente — le due componenti ugualmente fragili dell’essere umano — sono anche alla base della ricerca del protagonista del successivo Vital (id. 2004), del personaggio “ingabbiato” del mediometraggio Haze (2005) e dell’indagatore dell’incubo dei due episodi intitolati Night Detective (Akumu tantei, rispettivamente del 2006 e 2008), oltre che nel terzo episodio della trilogia dedicata a Tetsuo, cioè Tetsuo: The Bullet Man (2009, in concorso a Venezia).
Un cinema a suo modo profondamente politico, che rivendica il diritto all’esistenza in una dinamica di mercificazione degli individui. La svolta della metamorfosi fisica a quella mentale si accentua a partire da Kotoko (2011, Miglior Film nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema veneziana), in cui Tsukamoto estende anche la metafora della città a un mondo più ampio e senza limiti. Non si perde comunque l’idea che l’essere umano sia ridotto a un oggetto attraverso la sublimazione della sua pulsione di vita: ai suoi personaggi non resta che reagire con atti di forte violenza per far scaturire emozioni vitali, e infine, tra i tanti nessuno, il sacrificio di chi ha prodotto quell’unico grido determina un’eco potente.
Gli ultimi due film del regista, entrambi in concorso nella kermesse principale veneziana, proseguono la sua denuncia dell’iniquità della guerra: Fuochi sulla pianura (Nobi, 2014), adattamento dell’omonimo romanzo di Ooka Shohei, ne offre uno spaccato crudele, così come il più recente Killing (Zan, 2018), attraverso il ritratto di un “samurai pacifista”, ne svela la follia.
